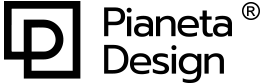Biennale Architettura: scopriamo Uccellaccio del collettivo HPO
Dopo Disaster Rooftops, La Terra delle Sirene e Sot Glas, ecco la quarta attivazione che ha il compito di tracciare la strada verso la Biennale di Architettura per quanto riguarda il lavoro svolto dal collettivo HPO e il padiglione italiano.

In attesa di ammirare il padiglione Italia, Spaziale: Ognuno appartiene a tutti gli altri, che sarà allestito dal collettivo Fosbury Architecture durante la prossima Biennale di Architettura a Venezia, è stata organizzata una fase propedeutica con degli appuntamenti itineranti.
Ad arrivare prossimamente sarà proprio Uccellaccio, la quarta attivazione realizzata a Ripa Teatina, in Abruzzo, grazie al coinvolgimento del collettivo di architettura HPO.
A svolgere il ruolo di advisor c’è la scrittrice Claudia Durastanti. Come incubatori di questa attivazione, invece, saranno coinvolti il MAXXI L’Aquila e il Comune di Ripa Teatina.
Addomesticare l’ecomostro

Ma su cosa si concreta nella pratica questa quarta tappa lungo la strada che porta alla Biennale? Il progetto si propone lo scopo di fare i conti con una delle tante costruzioni incompiute che sono presenti sul territorio italiano.
Quelle architetture incomplete, dunque, che non svolgono nessun tipo di funzioni e che, andando a gravare sul panorama naturale, si sono guadagnate il titolo di ecomostri.
Nel caso specifico di Ripa Teatina, si tratta di un’opera iniziata nell’ormai lontano 1973 e che non ha mai visto una fine. Nel corso di questi anni, però si è tentato più volte di portare a termine il lavoro, alternando il tutto con alcune ipotesi di demolizione.
Il risultato è una convivenza tra la comunità e questa struttura che, nonostante il suo evidente ingombro, sembra procedere con una sorta di rassegnazione.
Architettura come pratica di ricerca

Partendo da questa problematica, dunque, la Fosbury Architectureha cercato di applicare la propria interpretazione dell’architettura. Una visione all’interno della quale lo “spazio” è considerato come luogo fisico e simbolico, area geografica e dimensione astratta, sistema di riferimenti conosciuti e territorio delle possibilità.
Il che vuol dire che la progettazione e l’edificazione devono iniziare ad essere pratiche di ricerca andando oltre la semplice e meccanica costruzioni di manufatti.
Nello specifico, poi, proprio la progettazione dovrebbe rappresentare il risultato di un lavoro collettivo e collaborativo, in grado di andare ben oltre l’idea dell’architetto-autore.
“In architettura non esiste una controparte positiva al costruire. La demolizione non è un processo in sé, ma solo l’ineluttabile conclusione di una parabola – dichiarano i curatori, Fosbury Architecture – Crediamo che nella decostruzione e nello smontaggio selettivo si possa coltivare un futuro, anche economico, di rigenerazione sostenibile”.
In questo senso, dunque, si vuole delineare un utilizzo diverso degli strumenti architettonici che, sempre di più devono essere usati come via d’incontro tra l’espressione di una visione personale e il rispetto del territorio con cui ci si confronta.
Un passo necessario, dunque, per far in modo che l’architettura smetta di essere il veicolo di egocentrismi intellettuali.