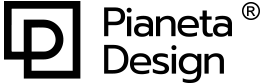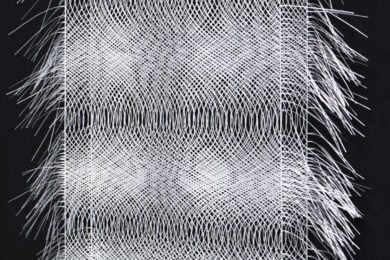MODERNO ABITARE: Nuove abitudini domestiche e dinamismo dei luoghi
La casa al centro di un nuovo dibattito: non più solo rifugio ma un vero e proprio hub creativo da cui connettersi con il mondo.

Specchio dei cambiamenti sociali, la casa ha subito storicamente grandi evoluzioni ed è stata al centro del dibattito degli ultimi cento anni con grandi slanci sperimentali che difficilmente hanno trovato una corrispondenza nella realtà dell’edificato. L’approccio tipologico resta costantemente legato a dinamiche culturali che mettono al centro il nucleo familiare e l’aggregazione standardizzata degli ambienti domestici.
Le abitudini sono mutate, il tema si è fatto urgente, ma il cambiamento è lento e faticoso. Nessun avvistamento delle ville in città di cui tanto si era discusso nell’ormai indimenticabile anno duemilaventi. Una chiara utopia quella di spingere le persone a pensare che la felicità potesse essere legata a qualche metro quadrato di verde insieme alla tanto ambita stanza in più per la cabina armadio. E’ inutile negarlo, lo spazio si è ridotto, le funzioni si sono amplificate. La geometria a disposizione non è quasi mai sufficiente a contenere tutto e non sempre perché abbiamo troppo. Studiamo e lavoriamo negli stessi luoghi in cui mangiamo e dormiamo e la famiglia, tradizionalmente intesa, non è più l’unico soggetto aggregativo all’interno del rettangolo domestico. Come possono gli standard edilizi adattarsi ai nuovi stili di vita?
In Casa Rebus (Giordana Ferri e Alessandro Scandurra, Letteraventidue) si sottolinea come gli standard vengono per lo più imposti da chi commercializza il prodotto “casa” inducendo nell’utente un bisogno che non sempre corrisponde alla necessità o ai desideri di chi fruisce di questo bene.

Occuparsi del progetto è urgente, forse ancor più che parlare di casa, non in termini storico-analitici ma di ricerca sui nuovi rituali domestici.
E’ fondamentale sensibilizzare le persone sull’evidente assunto che la casa non è un set, una board di Pinterest o un’allestimento scenografico da showroom, sottolineando invece il tema dell’abitatore cosi come racconta De Lucchi a proposito di Gio Ponti:
Gio Ponti non chiamava l’abitante delle sue case abitante ma abitatore perché abitatore introduce nell’idea di abitante anche l’accezione di qualcuno che partecipa all’abitare, che fa l’abitare, che in qualche maniera interviene nello spazio, lo genera, lo rende vitale e lo rinnova continuamente.

Siamo tutti abituati ad osservare rituali domestici. Ma cosa significa e perché sono veramente importanti? La lezione che abbiamo imparato da questi anni è che le nostre case non sono luoghi passivi: la casa senza di noi non esisterebbe, come non esiste senza gli oggetti intorno al quale e con i quali abitiamo. Siamo autorizzati a viverla come vogliamo e intorno a questo presupposto andrebbe progettata.
E. Coccia, nel suo libro Filosofia della casa edito da Einaudi, ci ricorda come ogni casa nasce, innanzitutto, attraverso un atto di elezione, una serie di gesti attraverso cui selezioniamo un insieme di oggetti che trasformiamo nel nostro mondo. Questo atto istintivo e quasi irrazionale è associabile alle nostre abitudini, gestualità con cui componiamo lo spazio: il modo in cui preferiamo cucinare, sederci sul divano, prendere il caffè. Non ci sono risposte univoche e non dovrebbero esserci regole.

Ma non è solo lo spazio al centro del moderno abitare, la struttura economica del nostro tempo e l’influenza che la nuova società globalizzata comporta, ha mutato il ruolo che abbiamo attribuito allo spazio domestico. Posizionata su un gradino più alto della scala dei valori personali, la casa è diventata per molti luogo di nutrimento e supporto emotivo. Il tema dell’appartenenza, come quello del dove, non è più cosi importante quanto quello dello stare bene, se pur temporaneamente, in un luogo che chiamiamo casa.